Di Palmiro Togliatti
In occasione dell’anniversario della fondazione del Pcd’I (21 gennaio 1921-21 gennaio 2026) viene proposta la quarta parte dello scritto di Palmiro Togliatti Il Partito Comunista Italiano che venne integralmente ripubblicato nel 2020 dagli Editori Riuniti a cura della nostra Associazione.
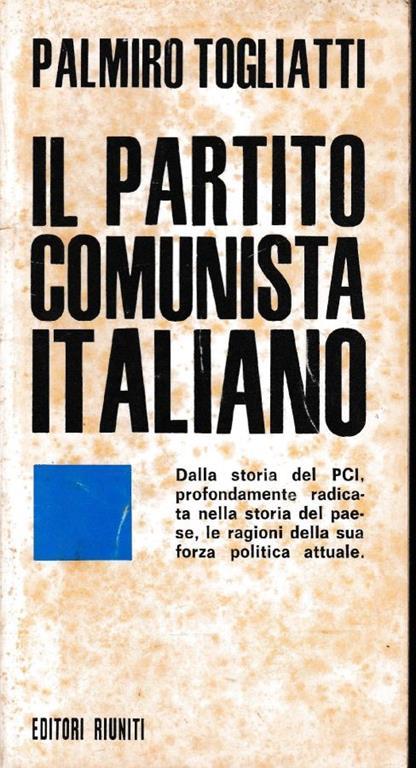
Pur riconoscendo che la creazione di un nuovo partito della classe operaia era una necessità, sorge la questione se l’averlo creato, rompendo l’unità del Partito socialista, proprio all’inizio del 1921, non sia stata causa di un dannoso indebolimento del movimento operaio e democratico, che si sarebbe dovuto evitare. Si era infatti nel momento in cui l’attacco violento e armato del fascismo contro le organizzazioni operaie si stava scatenando e l’unità del Partito socialista poteva avere un valore, se non altro difensivo. Ancora oggi, nelle polemiche correnti, e soprattutto quando noi comunisti facciamo appello alla unità delle forze democratiche e di classe, questa circostanza ci viene rinfacciata.
Orbene, la frazione comunista, che raccolse al congresso di Livorno 58.753 voti, non chiese, per rimanere nel vecchio partito, se non che da questo venissero allontanati i riformisti. Questi avevano 14.695 voti, mentre la maggioranza, che era dei massimalisti cosiddetti unitari, ne disponeva di 98.023. I massimalisti accettavano l’adesione alla terza Internazionale e le principali tesi politiche di questa; i riformisti le respingevano. Vi fu quindi, formalmente, una scelta della frazione di maggioranza, che preferì i 14.000 ai 58.000, e così rese la scissione inevitabile.
Questo argomento non tocca però il fondo delle cose. Bisogna rendersi conto del punto cui era arrivato, allora, lo sviluppo della crisi che il paese stava attraversando. Non può esser dubbio, per chi consideri la situazione oggettivamente, che il movimento rivoluzionario delle masse operaie e lavoratrici aveva già toccato il punto più alto e si trovava, oramai, in una fase discendente. Si ritiene, di solito, che il punto più alto fosse toccato nel settembre del 1920, quando, per iniziativa della organizzazione sindacale metallurgica, gli operai di questa categoria, e dopo di essi quelli di tutte le altre categorie industriali, compirono quella occupazione delle fabbriche che scosse da un capo all’altro tutta l’Italia. L’occupazione delle fabbriche fu certamente, nei primi anni del primo dopoguerra, il movimento popolare di più vasta portata e di più potente rilievo; in essa però, per il modo stesso com’era stata preparata e come venne attuata, erano già impliciti gli elementi di una sconfitta e di una ritirata generale. Occupare tutte le fabbriche del paese, cioè impadronirsi, di fatto, di tutto l’apparato della produzione industriale, è atto tale che non si può compiere con semplice intento dimostrativo, o al solo scopo di esercitare una pressione sul padronato. È un atto, infatti, che pone la classe operaia, in modo immediato, davanti al problema della gestione della ricchezza privata e della cosa pubblica, cioè del potere. La grande abilità di Giovanni Giolitti, che era in quel momento a capo del governo, fu di fingere di non accorgersene e quindi ricondurre il movimento, anche mediante questa sua astuzia, a un livello corporativo. Ma lo stesso fecero, per imprevidenza e insipienza, sia gli organizzatori sindacali che al movimento avevano dato inizio, sia la maggioranza del Partito socialista, con deliberazione che intervenne nella seconda metà del settembre, quando già nelle fabbriche i lavoratori erano stanchi ed era molto difficile pensare concretamente ad un passaggio dalla lotta sindacale a un attacco politico. Inoltre, quando l’occupazione delle fabbriche ebbe luogo già era in corso il processo di scissione del Partito socialista. Le differenti frazioni si stavano organizzando, contavano le loro forze, si opponevano in modo rigido l’una all’altra, non sentivano più, si può dire, di avere obiettivi di lotta comuni. Le polemiche già erano esasperate. La situazione era molto diversa da quella del precedente mese di aprile, quando a Torino gli operai erano scesi in campo per difendere i diritti dei loro organismi di fabbrica, si era fatto uno sciopero generale di dodici giorni e anche alla fine, quando si era dovuto interrompere l’azione per l’intervento delle direzioni nazionali sindacale e politica, il movimento conservava tutta la sua vitalità e il suo slancio, tanto che si stava estendendo a sempre nuove località del Piemonte e di altre regioni.
Si può quindi discutere se il punto più alto toccato dal movimento delle masse lavoratrici sia stato nella primavera o nell’estate del 1920; è però un fatto che, tanto nella primavera quanto nell’estate, la unità ancora esistente di tutte le correnti socialiste in un solo partito non servì a dare al partito la capacità di guidare al successo un movimento che si ponesse chiari scopi politici, di affrontare il problema della conquista del potere e avviarlo a una soluzione, o anche solo di condurre una azione che imponesse a tutto il paese e quindi al governo la necessità di alcune radicali riforme economiche e politiche. Lo sciopero torinese dell’aprile venne chiuso con notevoli conquiste di ordine sindacale e col riconoscimento di ampi poteri degli organismi di fabbrica; l’occupazione delle fabbriche mise capo alla firma di un concordato di lavoro assai vantaggioso per la categoria dei metallurgici e alla presentazione, da parte del governo, di un disegno di legge sul controllo operaio, che però non venne mai all’esame delle assemblee parlamentari. Nell’un caso e nell’altro non si riuscì ad andare oltre il consueto livello corporativo; le possibilità di un’azione politica non vennero utilizzate e le conquiste sindacali furono pagate con la stanchezza e la sfiducia che incominciarono a diffondersi tra le masse, con lo scetticismo, che incominciò a diventare generale, circa le effettive possibilità rivoluzionarie del Partito socialista. Mantenere ancora una esteriore unità non sarebbe servito a niente. Se i dirigenti nazionali avessero cercato di farlo, dal basso si sarebbe iniziato un processo non già di rinnovamento, ma di disorganizzazione e sfacelo, che sarebbe stato impossibile arrestare.
La constatazione che all’inizio del 1921 il movimento operaio già si trovasse in una fase discendente non vuole naturalmente dire che già tutto fosse deciso e non si trattasse che di tirar le somme, come avvenne con l’avvento al potere del fascismo nell’ottobre del 1922. L’offensiva aperta del fascismo contro le organizzazioni politiche, sindacali e cooperative dei lavoratori era incominciata, aveva già riportato alcuni successi importanti, come il rovesciamento violento dell’amministrazione comunale socialista di Bologna. Le grandi organizzazioni padronali dell’industria e della agricoltura avevano stretto le loro file ed erano decisamente orientate a sostenere con qualsiasi mezzo l’offensiva armata del fascismo. Le libertà democratiche elementari venivano negate e soppresse, per i lavoratori, in una parte del territorio nazionale che diventava ogni mese più estesa. La situazione politica generale era però lungi dall’essere decisa. Permanevano forti elementi di incertezza e ampie possibilità di movimento ai vertici. Alla base sussisteva nelle masse lavoratrici un fortissimo potenziale di resistenza e anche di azione offensiva, come venne dimostrato in alcuni dei più noti e drammatici episodi della aperta guerriglia di classe che si stava combattendo (a Sarzana, a Roma, a Parma ecc.). Quando sorse, in modo quasi spontaneo, ma non senza un incitamento di dirigenti politici borghesi, una organizzazione come quella degli Arditi del popolo, che si proponeva di respingere con la violenza la violenza fascista, si disegnarono le possibilità di un diverso sviluppo della situazione.
Del tutto vano è però il ricercare, oggi, ciò che allora si sarebbe potuto o non potuto fare. Importa ricordare ciò che in realtà avvenne, e che fu la paralisi, di fatto, di tutte le forze che sembra avrebbero dovuto fare ostacolo all’avanzata del fascismo. I dirigenti politici borghesi erano tutti orientati a tollerare e stimolare l’impiego della violenza contro il movimento operaio. Le squadre fasciste erano armate dal governo, protette e fiancheggiate dalle forze armate dello Stato. La complicità di fatto col fascismo non poteva non metter capo, alla fine, in un sopravvento di questo. L’ultimo e intimamente contraddittorio tentativo fatto da Giovanni Giolitti, di andare al governo per far rientrare il fascismo nella legalità, dopo averlo usato per abbattere le organizzazioni socialiste, fu reso impossibile, oltre che dalla tracotanza dei fascisti stessi, dalla posizione del partito cattolico, dietro al quale stavano le gerarchie vaticane, decise ad appoggiare il fascismo nella presa del potere. La corte, gli alti gradi dell’esercito, della magistratura e degli apparati dello Stato erano tutti orientati in questo stesso modo.
L’uscita dei comunisti dal vecchio partito aveva, perlomeno in apparenza, lasciato maggior libertà di movimento alle correnti riformiste del socialismo. Lenin aveva del resto espresso l’opinione che, cacciati i riformisti, si dovesse fare con essi l’unità per scopi politici immediati. Era un consiglio che prevedeva la possibilità di un certo coordinamento degli sforzi, per salvare la situazione, tra un movimento di massa guidato dai comunisti e gruppi democratici i quali conservassero una capacità di iniziativa politica e di movimento. Lo scopo doveva essere di provocare una svolta della situazione, isolare i fascisti e i loro alleati aperti e batterli. Ma nulla poté essere fatto in questa direzione, perché, anche dopo il congresso di Livorno, riformisti e massimalisti, proprio perché erano rimasti uniti in un solo partito, continuarono a paralizzarsi e annullarsi a vicenda. Gli uni proseguirono nella vuota e fatalistica predicazione rivoluzionaria, accompagnata, oramai, dall’invettiva contro i comunisti. Gli altri si dettero a incitare alla capitolazione e alla viltà davanti alla violenza del fascismo, cui non si doveva resistere, dicevano, per rendersi simili ai santi. Ibrido risultato del connubio di queste due incapacità fu un famigerato “patto di pacificazione” coi fascisti, concluso nell’agosto del 1921 e la cui sola conseguenza fu di disarmare la resistenza delle masse e consentire ai fascisti di raccogliere le forze per attacchi ulteriori. Altrettanto ibrido risultato fu lo sciopero generale, che fu detto “legalitario”, proclamato dalla Alleanza del lavoro nell’agosto del 1922, e che non poteva portare e non portò ad altro che a una nuova esasperazione della situazione. La forza che sarebbe stata necessaria perché quell’azione avesse un successo non esisteva più; le organizzazioni operaie erano state quasi tutte smantellate; la speranza di imporre con un puro sciopero generale un altro corso della situazione era del tutto irreale. Eppure, solo in quest’ultima fase i dirigenti riformisti avevano osato proporre apertamente la partecipazione al governo e Filippo Turati si recò, invitato da Vittorio Emanuele III, al Quirinale, compiendo un atto che, al punto cui si era arrivati, era assolutamente privo di qualsiasi portata politica, eccetto quella dell’umiliazione. Ma il Partito socialista andò, dopo questo, a una nuova scissione, al congresso di Roma dell’ottobre 1922: e la organica sua debolezza interiore, fonte della sua impotenza politica, fu ancora una volta dimostrata.
Non si può dire che in questo periodo l’orientamento e l’azione del Partito comunista, da poco costituito, siano stati adeguati alla situazione. Nel grande sconvolgimento di quegli anni, in cui crollarono tutte le strutture tradizionali del movimento dei lavoratori italiani, esso si presentò però già allora, nonostante le sue manchevolezze e i suoi errori, come il punto di partenza del necessario rinnovamento.
Gli errori e le manchevolezze furono in parte conseguenza della situazione stessa in cui si era trovata la classe operaia e del drammatico corso degli avvenimenti. Le condizioni oggettive di una rivoluzione vittoriosa si erano presentate. La vittoria riportata in Russia nell’ottobre 1917 aveva mostrato la possibilità di vincere, aveva reso concreta la prospettiva del potere operaio e del socialismo, aveva suscitato una ondata non mai vista di entusiasmo e di volontà combattiva. Gli operai di convinzioni politiche avanzate si erano gettati nella lotta sindacale e politica con slancio ed eroismo, realizzando prodigi di organizzazione e disciplina. Basti pensare al modo come, durante l’occupazione delle fabbriche, era stata assicurata la continuità delle lavorazioni, nonostante l’assenza dei direttori dei reparti e in molti casi anche dei tecnici, in una grande parte degli stabilimenti. La speranza di un mutamento radicale della posizione delle masse lavoratrici nella società e nello Stato si era diffusa ampiamente, anche fuori delle file delle avanguardie organizzate. Tanto più profonda quindi fu la delusione per l’esito del movimento, l’amarezza per l’assenza degli sviluppi che si erano attesi, la collera vera che invase l’animo dei quadri migliori, di coloro che più avevano fatto per strappare un successo decisivo, quanto si disegnò, invece di una vittoria democratica e socialista, l’avanzata del fascismo. Delusione, amarezza e collera si riversarono contro il vecchio Partito socialista, ritenuto responsabile della sconfitta, crearono una spinta fortissima alla rottura radicale con tutto il passato, con tutto ciò che al passato sembrasse fare richiamo, e quindi anche una tendenza a chiudersi in se stessi, non vedendo più altro compito che quello di costruire una diversa organizzazione politica, adeguata a compiti di combattimento, disciplinata, compatta, libera da qualsiasi influenza delle posizioni opportunistiche che avevano tolto al movimento socialista la capacità di muoversi in una situazione rivoluzionaria e di dominarla. La stessa idea della unità era considerata con diffidenza, perché si era visto come l’esteriore unità di tendenze contrastanti avesse paralizzato tutto il movimento.
Il nuovo partito sorse quindi con una marcata impronta di estremismo e di settarismo, che sarebbe errato, però, attribuire soltanto a errori e inesperienza dei suoi dirigenti, perché esprimeva, in grande parte, una reazione spontanea che partiva dal basso e conteneva in sé parecchi elementi positivi.
La direzione fu, nazionalmente e localmente, nelle mani di quella che si era chiamata frazione astensionista, perché nel suo infantile estremismo settario era giunta sino a negare la utilità della partecipazione dei partiti della classe operaia alle elezioni per il parlamento e alla attività parlamentare. Non era una tendenza né marxista né leninista, ma una semplice derivazione delle correnti che avevano interpretato le dottrine del marxismo in senso fatalistico. Rifuggiva dalla analisi concreta delle situazioni politiche, fatta allo scopo di stabilire una differenza tra i diversi gruppi politici e di determinare verso ciascuno di essi una posizione che tenesse esatto conto della sua natura sociale e dei suoi programmi. Negava quindi la grande varietà e contraddittorietà delle posizioni di classe e politiche in un paese di capitalismo sviluppato ma ricco di residui del passato, come l’Italia. Tendeva a mettere in un sol sacco tutto ciò che non fosse l’avanguardia cosciente della classe operaia. Di conseguenza isolava questa avanguardia e toglieva alla classe operaia la possibilità di svolgere, verso i differenti gruppi sociali e verso i partiti politici che ad essi corrispondono, una azione positiva, al fine di isolare le forze più reazionarie e stabilire le necessarie collaborazioni nella lotta per la democrazia e per il socialismo. Ci si doveva limitare alla denuncia propagandistica e alle lotte parziali di natura sindacale, nell’attesa di una situazione in cui il partito, organizzato come chiusa pattuglia di punta di un movimento rivoluzionario, si trovasse davanti al compito di guidare una rivoluzione alla vittoria.
Nel giudizio sul fascismo questa corrente sbagliò. Partì dalla giusta intuizione della natura di classe di questo movimento, ma ne trasse la conclusione errata di negare che esso tendesse a una trasformazione sostanziale dei modi e delle forme del dominio di classe della borghesia. Stabilì una identità tra il dominio borghese che si esercita nelle forme democratiche e il possibile dominio del fascismo. Non poté quindi più vedere la vera natura del colpo di forza che si compì con la marcia su Roma; affermò che non fosse altro, su per giù, che una farsa giocata tra uomini e gruppi sempre disposti, per la stessa natura loro, a procedere concordi nella lotta contro la classe operaia. Vi era del vero in quest’ultima constatazione, che veniva suggerita dai fatti stessi, nel momento in cui, alla vigilia dell’ottobre 1922, tutti gli uomini politici non sembravano preoccupati di altro che di trovare un terreno di accordo per portare al governo le camicie nere e collaborare con Mussolini. Ma proprio in quel momento sarebbe stata necessaria la presenza attiva di chi sentisse e mettesse in luce il drammatico significato della trasformazione profonda del regime politico che il fascismo preparava, partendo dalla violenza contro la classe operaia, ma tendendo alla distruzione di tutte le conquiste della democrazia. Soltanto questo avrebbe potuto essere il punto di partenza di un’azione veramente efficace, non soltanto verso le sfere politiche più elevate, ma anche tra le masse. L’azione del Partito comunista fu invece allora difettosa in tutte e due queste direzioni. La possibilità che si operasse una distinzione efficace, nei confronti del fascismo, nel vecchio personale dirigente politico, non la volle nemmeno prendere in considerazione; e se chiamò gli operai e i lavoratori a respingere gli attacchi dei fascisti con qualsiasi mezzo, il che era necessario e giusto, rese scarsamente efficace questo appello rifiutando di dare a tutta la sua azione quel carattere unitario che allora si imponeva. Volle perciò rimanere estraneo persino alla organizzazione degli Arditi del popolo, giustificando questa linea di condotta con considerazioni che, di fronte alle necessità urgenti del momento, in cui prima di tutto era necessario estendere la lotta portando in essa nuovi strati della popolazione, non avevano alcun valore. Può valere come attenuante che il fascismo e le sue prospettive erano fatti nuovi, di fronte ai quali tutti, allora, si sbagliarono. Certo è che una correzione di tutto l’indirizzo del nuovo partito si imponeva e presto ad essa ci si dovette accingere.
Questa valutazione critica non deve però farci ignorare tutto ciò che il Partito comunista rappresentò di nuovo e di positivo sin dalla sua creazione, sia nel movimento operaio che sulla scena politica del paese, in generale. Mi sia consentito sottolinearlo negli stessi termini in cui l’ho fatto in altro mio scritto.1
«… I 58.000 di Livorno erano veramente, nel loro assieme, la parte migliore, più giovane, più tenace, più intelligente e combattiva del Partito socialista. Erano in grande maggioranza operai. Se erano intellettuali, avevano per lo più rotto decisamente con la classe borghese. Avevano una esperienza diretta e vicinissima delle grandi lotte precedenti, che in loro non avevano lasciato stanchezza, ma proposito fermo di continuare a combattere, in qualsiasi condizione. A migliaia e forse a decine di migliaia si contavano tra di essi coloro per i quali l’adesione al movimento rivoluzionario della classe operaia voleva essere dedizione di tutta l’esistenza. Era quindi un vivaio sterminato di futuri ‘rivoluzionari professionali’, di quadri dirigenti che non sarebbero mai venuti meno, le cui qualità, anche morali, erano mille volte superiori a quelle del consueto, corrotto, logoro personale politico borghese. Era veramente la parte migliore della classe operaia italiana, che dalle circostanze stesse della storia era stata spinta a rompere con la vecchia organizzazione politica e a formarsi come partito, e in questo stava la sorgente più profonda della sua forza, la garanzia della sua capacità di resistenza e dell’avvenire del partito da essa formato.»
«Nonostante l’orientamento settario della direzione, questo legame diretto con la classe operaia e con il popolo non solo salvò il partito in questi suoi primi anni, ma lo collocò come avanguardia combattente agli occhi di milioni di lavoratori. Nei sindacati, dove il numero degli iscritti veniva progressivamente diminuendo e l’organizzazione si riduceva a poco a poco agli strati più consapevoli, i comunisti riuscirono, nonostante le persecuzioni e il filofascismo dei bonzi riformisti, a mantenere e persino ad allargare le loro posizioni… Quanto alla lotta più propriamente politica, quello che contava e decideva, allora, era la capacità di resistere, in qualsiasi modo, agli attacchi fascisti, e in questo i militanti comunisti non ebbero mai un attimo di esitazione. Dove si combatteva contro le camicie nere, dove si manifestava anche a costo della vita o si faceva sciopero per protestare contro la criminalità fascista, ivi i comunisti c’erano sempre, ed erano sempre in prima fila, esempio a tutti di coraggio, di abnegazione, di spirito di sacrificio sino all’ultimo. Incominciò il calvario dei nostri gloriosi caduti, dei nostri martiri, da Firenze a La Spezia, dalla Toscana all’Emilia, a Torino, a Milano. Città e campagne d’Italia cominciarono a essere irrorate del sangue di lavoratori che nel cadere tenevano alta davanti a tutti la bandiera del nuovo partito fondato a Livorno, asserivano la fede negli ideali di questo partito e col loro corpo facevano barriera all’avanzata di quelle forze antidemocratiche e bestiali cui andava in quel momento la fiducia di tutti gli esponenti – economici, politici, culturali – della borghesia, quasi senza eccezione. Avevano un bel presentare i comunisti come degli scriteriati, e persino alleati del fascismo. Le masse popolari vedevano i fatti, giudicavano, si orientavano. Il giudizio positivo sul nuovo partito incominciava ad affondare le radici nella coscienza dei lavoratori.»
Note
1 “Trenta anni di vita e lotte del PCI”, in Quaderni di Rinascita , n. 2, pp. 29 e segg. in P. Togliatti, Momenti della storia d’Italia, Roma, Editori Riuniti, 1963, pp. 117-163; ora anche in P. Togliatti, La politica nel pensiero e nell’azione, a cura di Michele Ciliberto e Giuseppe Vacca. Saggi introduttivi di Leonardo Pompeo D’Alessandro, Giuseppe Vacca, Francesco Giasi, David Bidussa, Silvio Pons, Michele Ciliberto, Milano, Bompiani, 2014, pp. 1578-9; l’intero scritto in quest’ultima edizione compare con il titolo Appunti e schema per una storia del Partito comunista, pp. 1565-1611
.
